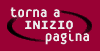Ricordi, sensazioni, stati d'animo espressi in forma letteraria o poetica, che abbiano come punto di riferimento la Neresine di ieri o di oggi. Non è necessario possedere particolari doti artistiche, basterà che esponiate le Vostre emozioni cosi come le percepite.
Marianna Camali Giachin - ADDIO NERESINE
P. Flaminio Rocchi - NERESINE L'ISOLA DEL VENTO
Sabino Buccaran - RICORDI DI NERESINE
Erano trascorsi quindici anni da quel triste giorno, in cui lasciai definitivamente il mio paese. Con il trascorrere del tempo sentivo il desiderio di rivederlo, tuttavia mai presi la decisione di fare quel viaggio.
Un giorno improvvisamente nel mese di settembre partii: con il pullman arrivai nella bellissima città di Trieste e dopo una fuggevole sosta, prosegui per la superba, cosmopolita città di Fiume, dei tempi passati. Notai la sua decadenza avvenuta nell’arco degli anni e della guerra. Poi su una piccola nave di linea giornaliera, mi imbarcai e mi sedetti in coperta. La giornata era splendida con sole smagliante ed il mare calmissimo. Da quella posizione dove mi trovavo poiché la nave costeggiava, ammiravo la bellezza di quei luoghi che a mano a mano mi passavano davanti agli occhi: vari porti di magnifici paesi, immersi in una vegetazione fiorente, rendevano piacevolissimo il viaggio mentre una leggera distensiva brezza mi sfiorava. Attraversammo lo stretto di Faresina ed entrammo nella baia dell’isola di Cherso: antica città veneta da rivisitare con interesse, ma la sosta troppo breve della nave mi impediva di scendere, per cui le diedi soltanto uno sguardo da lontano. E qui mi immersi nei miei ricordi quando quindici anni orsono rifeci da Cherso questo viaggio inverso per raggiungere l’altra sponda, in condizioni drammatiche.
“Era l’anno 1947, abitavo con mio marito e mia figlia a Pola. In quell’epoca dopo varie vicissitudini la città si stava preparando al famoso “esodo”. Già da gennaio il piroscafo Toscana effettuava i viaggi tra Pola – Ancona – Venezia trasportando tutti coloro che avevano optato “per l’Italia”. La tragedia ebbe inizio e noi pure ne fummo coinvolti e alla metà di febbraio, mentre fervevano i preparativi per la partenza sentii un forte desiderio di recarmi a Neresine a salutare mia madre, che non vedevo da alcuni mesi e dei parenti. Ero convinta, che l’esodo portandomi via definitivamente dall’Istria, mi avrebbe impedito di rivedere Neresine. Decisi di partire, ma mio marito non approvava questo viaggio, non ritenendo il momento propizio per allontanarmi, data la situazione politica molto tesa e la mia posizione di profuga. Comprendeva questo legittimo desiderio, che mi assillava e così alla fine si lasciò convincere, con la promessa che la mia permanenza in paese sarebbe stata brevissima. Partii e appena giunta a Neresine, corsi da mia madre, che, vedendomi arrivare così all’improvviso non seppe frenare la sua emozione. Erano anni che mancavo da casa mia, per cui il primo impatto mi fece l’impressione di profonda tristezza. Era di un ordine perfetto come non fosse abitata, mi inoltrai nelle stanze ad una ad una in un silenzio assoluto, sembrava la casa dei fantasmi. Ma dov’è la mia famiglia di origine? Papà scomparso da qualche anno, ma Lino, Tino e Rino a 21 anni ufficiale di marina, il nostro eroe medaglia d’argento al valor militare e la birichina Ileana? Non ci sono tracce di loro, essendo partiti. Ricordai quanto la famiglia era unita e noi giovani, in particolare i fratelli al loro ritorno facevano risuonare la casa di allegria spensierata, tra scherzi reciproci, litigate e canti e poiché essendo dotati di belle voci formavano un bel coro. Con la loro fresca giovinezza portavano un soffio di primavera in tutte le stagioni. Ormai quel tempo è finito e non ci si rivedrà uniti mai più, rimarrà solo un ricordo di un passato indimenticabile. Affacciata alla finestra della stanza, che una volta mi apparteneva, la pioggia ed il vento di scirocco mi impedivano la visuale. Riandavo allora con il pensiero quando molti anni orsono da questa stessa posizione ammiravo il bellissimo panorama con il cielo azzurro come il mare e al tramonto seguivo con lo sguardo, le piccole imbarcazioni dalle vele bianche come farfalle, scivolare sull’onda spinte dal vento che allietavano la vista, contribuendo a farmi fantasticare e sognare nei miei anni giovanili. Nonostante il persistere del cattivo tempo, volli dare un ultimo saluto al Paese: mi recai in piazza, privata dell’antico grazioso pozzetto e ricordai quando nel periodo di carnevale si ballava con tanta allegria. Indi salii la scalinata per una visita alla chiesa, ove un giorno lontano mi sposai felicemente; percorsi la riva fino al faro: il vento si era attenuato, ma il sole neppure per un istante fece capolino, mentre il cielo si manteneva plumbeo. Il posto era squallidamente vuoto, dove sono i motovelieri che sostavano alternandosi e nei giorni di festa alzavano il “gran pavese” vanto e orgoglio di Neresine? Scomparsi.
Dopo tre giorni di permanenza venne il doloroso commiato, oltre a mia madre e zia Maria salutai i parenti e le nonne che non avrei più rivisto, in particolare la materna, che io consideravo la mia seconda madre. Ed ora ti lascio casa straniera, non varcherò più la tua soglia, ma conserva il ricordo di noi, che qui siamo vissuti ed è qui che è esplosa la nostra giovinezza: me ne andai senza voltarmi con un dolore struggente. Accompagnata dai parenti mi avviai a prendere la corriera, che stava per arrivare, mi congedai da tutti con profonda emozione. Il veicolo era semivuoto e così potei in solitudine sfogare il mio dolore; con le lacrime che mi rigavano il volto osservai dal finestrino appannato dalla pioggia durante il percorso quella stupenda terra, che non avrei più rivisto. Addio Neresine, sei stata venduta come le tue consorelle istriane e noi per non sottostare all’ombra di una bandiera straniera optammo tutti compatti, incamminandoci là, dove sventolava il nostro tricolore ma ti abbandoniamo, dolce paese, con dolore tu che hai dato i natali a gente di razza bella, intelligente, lavoratori, capitani, professionisti ed eroi senza contare quei baldi giovani, che partirono per la guerra: i prediletti, dei quali attendesti invano il ritorno.
Quando sarò lontana ti prometto che nei momenti di nostalgia pensandoti, percorrerò le tue strade, salirò le tue colline, sosterò ad ammirare il tuo stupendo panorama.
Di ritorno a Pola mi attendeva un altro congedo, una partenza dall’Istria senza ritorno, verso un incerto futuro. Non sorridevo da tempo, quell’espressione di gioia e di allegria, che illumina il volto era inesistente, le angosce, le preoccupazioni lo avevano spento.
La corriera sballottando un po’ da una parte all’altra percorreva il tratto dell’isola di Cherso, il lago di “Vrana” ed i paesi distanziati l’uno dall’altro in posizioni magnifiche erano da ammirare con una disposizione d’animo diversa da quella, che provavo in quei momenti. Finalmente arrivai a Cherso per prendere il piroscafo diretto all’altra sponda. Scesa dalla corriera, mi avviai al porto in attesa della nave da Fiume, ma mi stupì il fatto di non vedere alcuno ad attenderla, per cui mi rivolsi ad un portuale, il quale mi informava che a causa del pessimo tempo nessuna imbarcazione sarebbe arrivata; né partita. Ero costernata, avevo urgenza di partire ad ogni costo; ad un tratto osservai in fondo alla riva una signora ferma di fronte ad una motovedetta militare, che dai preparativi si intuiva stesse per salpare. Mi avvicinai e lei mi disse di aver chiesto al capitano un passaggio verso Albona, dove era diretto; mi affrettai a formulare la stessa richiesta ed egli gentile, accondiscese ad imbarcarci. Era una follia intraprendere quel viaggio, ma me ne accorsi troppo tardi: salimmo a bordo entrambe ed entrammo nella minuscola cabina del comandante, sedendoci su di una panchina, mentre egli teneva in mano il timone. Partimmo, ancora dentro la baia di Cherso il mare iniziò ad aggredirci per il fortunale di scirocco, facendo rollare l’imbarcazione in tutti i versi. Entrati nel canale di Faresina il mare si era rafforzato per una pioggia dirotta e la motovedetta si trasformò in un sommergibile e attraverso gli oblò si intravedevano le onde che ci travolgevano. Nella cabina, dove ci tenevamo strette per non cadere, regnava un silenzio assoluto: nessuno dei tre parlava, ognuno con i propri pensieri. Il capitano era yugoslavo, non conosceva l’italiano e durante tutto il viaggio non si svolse mai. Intanto la paura si era impadronita di me, ciononostante volli sapere da lui cosa ne pensava della nostra situazione: in slavo osai chiedergli se saremo riusciti a salvarci. Egli imperterrito, senza girarsi, rispose asciutto nella stessa lingua “speriamo compagna”. Questa risposta così drammatica detta da un esperto mi sconvolse, mentre la donna rincarò la dose dicendomi: “La ga sentio signora, qua moriremo tutti bisogna raccomandarsi l’anima a Dio” “EEh noò, non raccomando un bel niente, poiché devo vivere”. Ma come potevo pensare alla morte, io che mi sono salvata durante la guerra, correndo verso i rifugi come una gazzella sotto i bombardamenti? Ma per lo meno allora tentai di salvarmi, ma qui rischiavo di morire come un topo. Pensai ai miei cari, alla mia bambina, che aveva ancora tanto bisogno di me, a mio marito al quale avevo promesso di ritornare prestissimo ed io, questa promessa dovevo mantenerla, poiché era debito.
Sbirciai la vecchia: teneva in mano il rosario e osservai che i grani scorrevano più veloci del consueto tra le dita tremanti, certamente si raccomandava a Dio come aveva detto; ma io non riuscivo a pregare, a concentrarmi. Seguivo con gli occhi fissi la minuscola prua, che si immergeva e risaliva ogni pochi secondi col terrore di vederla inabissare. Avevo perduto la nozione del tempo, non so quanto durò la traversata, poteva essere breve o meno breve, ma nel corso della mia vita non scordai mai quel viaggio.
Eravamo vicini all’altra sponda, ed il capitano si diresse verso la parte più stretta del canale e così costeggiando trovò il mare più calmo e finalmente arrivammo a destinazione. Prima di ringraziare e salutare il capitano gli chiesi quanto fosse stato pericoloso il viaggio, mi rispose “Oltre il mare molto forte, il pericolo maggiore consisteva nelle mine vaganti sparse in quel tratto di mare agitato a causa del sciroccale”.
Rimasi allibita, fortuna volle che io ignorassi a quale morte andavo incontro, il destino poteva scegliere: o inabissarsi in fondo al mare, oppure saltare in aria, non lo fece, forse Dio non lo permise.
Quando scesi dalla motovedetta e sentii la terra sotto i piedi, mi feci il segno della croce”.
Mentre rifiorivano i miei ricordi il piroscafo con il ritmico rumore delle macchine, scivolando sull’onda appena mossa, ci portò imboccando l’estrema punta dell’Isola sotto Lubenizze. La giornata volge al tramonto, il sole all’orizzonte va sparendo piano, piano e mi offre una visione incantevole, mentre mi appare maestoso e solitario il monte di Ossero con sulla vetta una minuscola chiesa e poi scende a picco su quel vasto azzurrissimo mare del Carnaro.
Ci stiamo avviando verso il porto di San Martino, sulla riva rare persone conversano e nel silenzio, si odono le loro voci che l’eco diffonde lontano. Continuiamo il viaggio, attraversando quella bellissima baia, che divide l’isola di Cherso e Lussinpiccolo e ci avviciniamo all’ultima tappa. Si intravede l’antichissima cittadina di Ossero con il suo caratteristico campanile, che si scorge da notevole distanza e divisa da Neresine solo da qualche chilometro.
Percepisco nell’aria un profumo di bosco, di alloro, di salvia: ma sì, è quello inconfondibile della mia terra, che io aspiro con voluttà: tra breve sarò a Neresine, questo mio paese, adagiato in riva al mare tra le rocce con le case sparse ovunque, è graziosissimo. L’emozione sale, mentre il cuore accelera i suoi battiti. E pensare che molti anni addietro, quando me ne andai per l’ultima volta, non avrei mai immaginato di poter gioire nel rivedere ancora, questo mio caro, amato paese natio.
Neresine era un paese audace. Era posto come una sfida contro il vento del nord. Tutti gli altri paesi dell’isola si erano nascosti alla violenza della bora dietro le colline. I neresinotti sono gli unici che hanno voluto affrontare in faccia le raffiche di centocinquanta chilometri all’ora.
Tutte le case hanno voltato le schiene dure e grezze contro il vento. Le finestre sono piccole con gli stipiti grossi di pietra bianca e levigata. Erano di pietra perfino le grondaie lungo l’orlo dei tetti, sostenute da mensole in pietra, perché quelle di zinco sarebbero state strappate dal vento. Non c’erano persiane, ma scuri di legno, grossi e pesanti, chiavardati, sprangati da lunghe barre di legno.
Il vento fischiava sui tetti e sulle fessure delle finestre. Faceva vibrare come corde di violini i rami secchi e le sartie delle barche. Le chiome degli alberi erano pettinate all’indietro. Le folate di vento trasportavano polvere di mare. Le pecore si riparavano dietro le masiere.
Senza vanità poetiche noi, ragazzi, ci sentivamo figli del vento. Si correva giù dal colle verso la bora, sollevando l’estremità della giacca sopra la testa, come un’ala. Tu sentivi l’ebbrezza del vento che ti sollevava, che entrava in bocca e nella camicia. Sentivi il fresco che ti accarezzava, ti graffiava, ma ti piaceva. Ti avvicinava ai gabbiani sopra il mare, alle cornacchie sopra i campi arati che volteggiavano e cabravano come alianti.
Nuotare sul mare piatto è da rana. Ma era bello provare l’esaltazione del nuoto perforando le onde o arrampicandosi come delfini e poi scivolare nella schiuma del solco liquido.
Un canale di circa tre chilometri separava Neresine dall’isola di Cherso. Era una piazza per i venti che vi si intrecciavano, impazzivano. Era un piacere lanciarsi nella danza con una barchetta a vela. Mi vedo ancora ragazzo, in costume da bagno, seduto a poppa, con la barra del timone vibrante in mano e con la scotta della vela avvolta nell’altra, i piedi puntati contro la panchina, lanciato in una lotta entusiasmante contro le onde e contro le volate improvvise. La barca fuilava come una lancia veneziana e fendeva la schiuma con la prua tagliente.
Al tramonto i contadini rientravano da bora con una vogata lenta e stanca. Se c’era vento issavano la vela. Entravano solennemente nel mandracchio con due grossi baffi bianchi a prora. Al centimetro giusto viravano. La vela sbatteva. La prua girava e baciava la riva dell’ancoraggio. Se la bora era molto forte, il contadino non alzava la vela. Legava a prua una fascina. Si sedeva a poppa al timone e si lasciava trasportare dal vento. Le donne osservavano dalle finestre le barche che comparivano e scomparivano tra le onde ed entravano nel porticciolo come da una passeggiata. Sfidare, dominare, gustare il mare.
I temporali avvolgevano la piccola isola come una ribellione selvaggia dal cielo e dal mare. S’affacciavano con nuvoloni grigi sopra le cime del monte. Si annunziavano con tuoni fragorosi che rotolavano minacciosi giù per i canaloni ripidi 558 metri. I lampi scoppiavano nella nuvolaglia nera con bagliori ramificati, taglienti come sciabolate. Un vento denso lasciava cadere i primi goccioloni. Le galline si ritiravano sui trespoli del pollaio. La capra legata all’albero, girava e belava nervosa. Le donne tiravano in fretta il telone sui fichi che si asciugavano. Raccoglievano la biancheria. Sprangavano gli scuri delle finestre. Accendevano in un bicchiere davanti all’immagine della Madonna un lumino ad olio.
Il vento, carico di acqua, frustava e piegava gli alberi. La pioggia scrosciava e scendeva in cento ruscelli giù per i canaloni. Gorgogliava e trascinava terra e arbusti che, a valle, formavano gli orti.
Ma il fortunale scatenava anche una battaglia marina. All’inizio le raffiche correvano a ventaglio sulla superficie del mare come streghe impazzite. Poi il mare si gonfiava, bolliva, si infuriava, alzava la cresta, e s’infrangeva violento rombando contro la scogliera, schizzando in spruzzi schiumosi, altissimi. Le onde si ritiravano con la risacca,, si rigonfiavano e tornavano a rovesciarsi sui massi, volavano a brandelli, si polverizzavano contro gli alberi e contro i tetti delle case. I gabbiani spiavano dall’alto e, avvistato tra le onde un pesce incauto, stringevano le ali sui fianchi e vi si lanciavano come un aereo silurante.
Qualche volta, durante i fortunali più rabbiosi, all’ingresso del canale, tra Punta Croce e Lussino, appariva una tromba marina: vento vorticoso che si avvolgeva come una colonna a spirale verso l’alto fino a raggiungere venti, trenta metri. Era una proboscide nera e gigantesca che annaspava veloce sul mare ed era capace di artigliare e di sollevare barche e bragozzi, tetti e alberi per poi sciogliersi per esaurimento lasciando cadere la preda. I velieri ne scrutavano la rotta e cambiavano la direzione a tutto motore. Per il marittimo questi fenomeni presentavano una forza misteriosa. Per questo l’antica mitologia li identificò con la divinità e chiamò il mare Nettuno e il vento Eolo.
Neresine aveva 39 velieri a vela e a motore. Navigavano nell’Adriatico e nel Mediterraneo con sei e otto uomini di equipaggio. Mio padre e lo zio Giuseppe Marinzulich avevano una splendida goletta di 120 tonnellate. Sembrava un panfilo con lo scafo bianco, la carena rossa e la coperta tirata a olio. Aveva una cabina con oblò e un timone a ruota. Avevo undici anni e mio padre mi mise al timone durante un viaggio fino a Venezia: “ora comanda tu”. E’ impossibile per un uomo di terra ferma immaginare l’orgoglio di un ragazzo che dirige un vascello così fantastico con le dodici vele bianche, gonfie di vento. Filava verso la costa a cinque miglia all’ora, piegato su un fianco. “Molla” – gridavo ai marinai con la vocina bianca. Essi scioglievano le scotte. Io viravo. Le vele cominciavano a sbattere. La nave riprendeva velocità. Le vele cominciavano a riempirsi di vento. La barca si piegava mostrando il labbro rosso della carena come un sorriso. A prua gorgogliavano due baffi di schiuma bianca. Mi sentivo l’ebbrezza di un ragazzo che aveva nelle sue piccole mani la maestà e la velocità di un gabbiano fantastico che volava nell’azzurro del mare e del cielo.
Poi l’abito francescano m’ha tenuto per cinque anni a Monselice, nella pianura padana: il regno della nebbia densa e umida mi stagnava, impigliata nei rami secchi degli alberi. Gli zoccoli di legno sollevavano zolle di terra appiccicosa. I geloni arrossavano e gonfiavano le alluce dei piedi. Io studiavo teologia alla luce opaca di un finestrino con una coperta sulle ginocchia. Vivevo come un vecchio precoce e naturalmente spento. Fuori non c’erano orizzonti e gli uomini si muovevano come ombre. Sognavo come un gabbiano la luce, le trasparenze della mia isola ventosa, l’immenso azzurro del mare e del cielo limpidissimo. Tacevo perché i frati della padana avrebbero detto che ero una capra, un uccello selvatico.
Passai poi un anno nella laguna di Venezia, nell’isola di S. Francesco del Deserto: “Beata solitudo, o sola Beatitudo”. Una piccola isola, immersa nel caligo. Un nido di verde per i mistici che guardano soltanto in alto. Il mare era torbido. Le onde, lente e lunghe, si rivoltavano nella sabbia. Erano stanche e sporche. Sul fondo vegetavano le sogliole schiacciate, le granzievole molli, i pesci bianchi e flaccidi. Pensavo alle onde del mio mare che si inseguivano a cavalloni, che sorridevano con le criniere bianche, agli sgombri, ai dentici e ai riboni argentei, agli scorfani rossi e ossuti per il “brodeto”, ai granchi giganti da scoglio dal colore verde bottiglia e giallo, dalle chele minacciose come due tenaglie. Neresine per un esule è un sogno, un’isola del vento che galleggia nell’azzurro del mare e nella luce del sole.
La scota
“Mai e poi mai ligar la scota” diseva el papà quando imparavo bordisar.
Podevo gaver diese ani quando la mia sorela ga voludo venir con mi a sgombri. E cosa ghe dirò che no? Così un bel dopopranzo de fresca baveta semo andà fora a vela verso dove se ciapava sgombri.
Preparada la panula cola pezeta bianca sui due ami, la galegiante per ela e la fonda coi piombini per mi, la go lassà via drio bordo.
Non xe pasà cinque minuti che tutti due gavemo incozà pese. Presto tira su, discoza i sgombri, taighe la panza per nova esca e buta dinovo in mar. Iera un spetacolo, come i ami tocava el mar, el pese se butava e, in poco tempo, la situazion se ga complicà.
Intrigado con la sorela, con la ribola del timon, con la scota dela vela, le togne che se ingropa, cosa go fato? Go ligà la scota! La go ligà atorno un schermo con un parlar.
Ocupado come iero, non go visto il refolo de vento che per poco ne ribalta. Per fortuna gavemo solo imbarcà acqua e, el più importante, nissun ne ga visto.
Con tute ste peripezie, lo steso semo vignù a casa con 89 sgombri.
I veci de una volta
“Disighe Bon Giorno a quei che ti incontri per strada e no stame far bruta figura” me diseva el papà.
Dio guardi te cascava un remo in mar, iera sempre qualchedun che ghe contava.
I veci ciacolava sempre sentadi sui mureti in piaza o in porto. I vedeva e criticava tuto quelo che noi mularia fazevimo.
Adeso inveze i xe dai Frati, in quel cimitero rente el mar che, quando xe bonaza, se li sente dir:
“I mii xe in America” dise el primo.
“I mii in Canadà”
“Xe meo in Australia” dise el terzo.
“Ma che, in Italia xe meo de tuto perché xe vizin e così i ne vien visitar più speso”, dise el quarto.
Dai “Ricordi di Neresine” (2007) di Sabino Buccaran, Wading River, New York
Flavio Asta Presidente e Webmaster del sito
 E-mail: astaf@libero.it
E-mail: astaf@libero.it